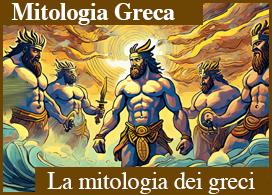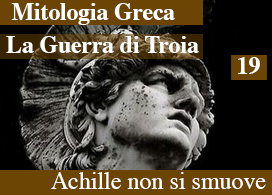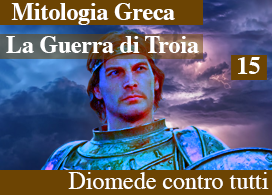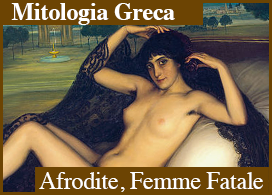A Caccia di Criminali
Chiamate anche Eumenidi, e dai romani Furiae o Dirae, in origine non erano altro che una personificazione delle maledizioni pronunciate contro i criminali colpevole. Il nome Erinys (Ἐρινύς), che è quello più antico, derivava secondo i Greci da ἐρίνω (erinō) o ἐρευνάω ( ereunaō ), “Caccio o perseguito”, o dal vocabolo arcadico ἐρινύω (erinyō), ” Sono arrabbiato”; così che le Erinni erano o le dee irate o le dee a caccia di criminali e che li tormentavano.
Erano quindi divinità della vendetta, le quali avevano il compito di perseguitare chi si era reso colpevole di qualsiasi violazione dell’ordine morale specialmente nel cerchio dei rapporti di famiglia
Il nome Eumenide, che significa invece “le buone intenzioni” o “le dee placate”, è un semplice eufemismo, perché la gente temeva di chiamare queste spaventose dee con il loro vero nome e si diceva che fosse stato loro dato per la prima volta dopo l’assoluzione di Oreste presso la corte dell’Areopago, quando l’ira delle Erinni si era ormai placata. Fu con un simile epiteto che ad Atene le Erinni furono chiamate σεμναἲ Δεαὶ (semnai Deai) o le venerabili divinità. Servio, grammatico e commentatore romano della fine IV secolo, fa una distinzione secondo la quale esse portavano il nome di Dirae quando venivano concepite come creature cielo, venute dal trono di Zeus; ma diventavano invece Eumenidi, quando venivano considerate come esseri della terra e Furiae in quanto spiriti del mondo degli inferi; ma questa sembra essere una classificazione puramente arbitraria.
Come fu che Le Erinni divennero Eumenidi: la storia di Oreste
Le Erinni, come altre deità infernali avevano un doppio aspetto, uno terribile, e l’altro più mite e quasi benevolo, così anche le Erinni vennero ad avere un significato buono; questo specialmente in connessione colla leggenda di Oreste.
Costui colpevole di aver vendicato la morte di suo padre Agamennone uccidendo la madre Clitemnestra insieme con l’amante di lei Egisto, era perseguitato dalle Erinni; errò molto tempo sulla terra non trovando pace ; ma a Delfi fu protetto da Apollo, il quale dopo molti riti di espiazione lo mandò ad Atene perchè là fosse giudicato dal celebre tribunale dell’Areopago presieduto dalla dea Atena. Anche là lo seguirono le Erinni assetate di sangue; ma chiuso il dibattimento, a parità di voti, avendo Atena stessa ed Apollo votato in favore di lui, fu assolto. Le Erinni volevano far le loro vendette su Atene disertando i raccolti, e portando calamità a tutta la terra; ma infine furono placate da Atena, colla promessa che sopra il colle dell’Areopago sarebbe sorto un tempio a loro dedicato. Così le Erinni si piegarono, ridonarono pace e prosperità all’Attica, e col nome di Eumenidi “le ben disposte”, e Semne, Le Venerande, vennero onorate dagli Ateniesi quali Dee benefattrici, terribili bensì contro i colpevoli, ma benigne verso chi si pentisse e latrici di beni agli onesti.

Nel senso di maledizione o di maledizioni, la parola Erinys o Erinnyes viene spesso usata nei poemi omerici ed Eschilo chiama le Eumenidi Ἀραί (Arai), cioè appunto “maledizioni”. Secondo la nozione omerica, le Erinni, che il poeta concepisce come esseri distinti, sono annoverate tra coloro che abitano l’Erebo, dove riposano finché un’anatema pronunciato su un criminale le richiama alla vita e all’azione. I reati che puniscono sono la disobbedienza verso i genitori, la violazione del rispetto dovuto alla vecchiaia, lo spergiuro, l’omicidio, la violazione della legge dell’ospitalità e la condotta impropria verso i supplici. L’idea che sta alla base della fede delle Eumenidi sembra essere che una maledizione toglie a colui contro il quale essa viene pronunciata, ogni pace dello spirito, distrugge la felicità sua e della sua famiglia e impedisce che sia benedetto con dei figli.
Poiché le Erinni non solo punivano i crimini dopo la morte, ma anche durante la sua vita sulla terra, erano concepite anche come dee del destino, che insieme a Zeus e alle Moire o Parche, conducevano gli uomini condannati a soffrire, nella miseria e nelle disgrazie. Per questo loro ruolo, esse impedivano anche di ottenere una conoscenza troppo chiara del futuro. Omero non menziona alcun nome particolare delle Erinni, né sembra conoscerne un numero definito. Esiodo, che tace parimenti su questi punti, chiama le Erinni figlie di Gea, che le generò dalle gocce di sangue che caddero su di lei dal corpo di Urano, sicché il primo delitto di sangue nella più antica famiglia divina si supponeva avesse generato subito lo spirito della vendetta e della punizione. Epimenide chiamava le Erinni figlie di Crono ed Eurinome e sorelle delle Moire; Eschilo le chiama figlie di Nyx (la Notte) ; Sofocle di Scotos (Oscurità) e Gea.
Dee infernali o celesti?
Nei tragici greci, come ad esempio nelle Eumenidi di Eschilo, il numero di queste dee non è ristretto a un numero esiguo, ma non viene ancora menzionato alcun nome particolare di nessuna delle Erinni; esse appaiono sempre nella stessa veste, come le vendicatrici dei crimini, come in precedenza. A volte sono identificati con le Poenae, sebbene la loro sfera d’azione sia più ampia di quella di quest’ultime. Per aver cacciato e perseguitato il criminale maledetto, Eschilo le chiama κύνες (kynes) o κυνηγέτιδες (kynēgetides). Nessuna preghiera, nessun sacrificio e nessuna lacrima possono commuoverle o proteggere chi è designato alla loro persecuzione; e quando temono che il reo possa loro sfuggire, chiedono l’assistenza di Dike, con la quale sono strettamente legati, poiché il mantenimento di una severa giustizia è il loro unico scopo.
Le Erinni erano tra le divinità più antiche degli dei dell’Olimpo e quindi non sottostavano al dominio di Zeus, sebbene lo onorassero e lo stimassero; abitavano nelle tenebre profonde del Tartaro, temute dagli dèi e dagli uomini. Il loro aspetto è descritto da Eschilo come simile a quello delle Gorgoni, erano ricoperte di vesti nere, avevano dei serpenti attorcigliati nei capelli e il sangue scorreva dai loro occhi; Euripide e altri poeti successivi, le descrivono come esseri alati, ma è la descrizione che ne fa Eschilo che si è mantenuta inalterata in tutta la mitologia classica. Tuttavia, a poco a poco assunsero anche il carattere di Dee che punivano i delitti dopo la morte e che di rado apparivano sulla terra.
In svariante fonti, anche se non in tutte, viene riportato che il numero delle Eumenidi fosse limitato a tre (il primo a parlare esplicitamente di tre Erinni fu Euripide) e i loro nomi, noti solo nell’età Alessandrina, erano Tisifone (la punitrice dell’omicidio), Aletto (la inquieta) e Megera (l’odiosa) . Ad Atene c’erano di esse soltanto due statue.
Culto
I sacrifici che venivano loro offerti consistevano in un pecora nera e nella nephalia, cioè una bevanda a base di miele mescolato con acqua. Tra gli oggetti a loro sacri vengono citate le tortore bianche e i narcisi. Le Erinni erano adorate ad Atene, dove avevano un santuario e una grotta presso l’Areopago: nel quale si celebrava una festività, l’Eumenidea, in loro onore. Le statue ad esse dedicate, però, non avevano nulla di distintivo. Un altro santuario, con un boschetto in cui nessuno poteva entrare, si trovava a Colono. Sotto il nome di Maniai (Μανίαι), erano venerate anche a Megalopoli. Erano oggetto di culto anche sull’Asopo e a Cerineia.
Non solo in Atene le Erinni erano oggetto di culto, ma anche ad Argo, a Sicione, nell’Arcadia, nell’Acaia, e generalmente con un nome esprimente il loro aspetto buono, come Eumenidi o Semne, Potnie (venerande) o Ablabie (innocenti). Loro attributo costante nel culto era il serpente, simbolo in genere delle divinità ctoniclie. Nell’Attica era loro sacro il colle e il bosco di Colono, dove venne a cercar pace l’ infelice Edipo dopo esser stato tutta la sua vita perseguitato dalle Erinni per delitti involontariamente commessi. Alle Erinni si sacrificavano pecore nere, e si facevano libazioni senza vino, di miele misto con acqua.</p>
Iconografia
Nel Teatro, sulla scena, e nelle opere d’arte in generale, il loro aspetto terrificante veniva molto attenuato, poiché erano rappresentate come fanciulle dall’aspetto grave e solenne, vestite di abiti da cacciatrici, riccamente ornati, con una fascia di serpenti intorno al capo e ancora serpenti o torce nelle loro mani. A Roma si trova una testa scolpita di una delle Erinni dormiente (età ellenistica, II secolo a.C.)

Erinni dormiente Collezione Ludovisi
Furono i poeti tragici che più contribuirono a svolgere il concetto delle Erinni e a diffondere tra la gente un’immagine di esse viva e paurosa. Nessun crimine, si diceva, sfugge al loro acuto sguardo, e appena scorto il delitto, subito con implacabile severità si mettono alle calcagna del colpevole, e non lo abbandonano più; la loro presenza colla faccia di Gorgone, colla testa anguicrinita, incute un indicibile spavento; l’infelice non ha scampo; per quanto tenti, non riesce a sfuggir loro ; le fiaccole ch’esse portano in mano rischiarano d’una sinistra luce i passi del reo, e il suo tormento non ha più fine se non quando egli impazzisce e muore.
Le Furie dei romani
I Romani chiamarono Furie le Erinni, e senz’altro s’appropriarono i concetti e le leggende ad esse relative. Ma una vera Deità italica rispondente alla greca non pare ci fosse; si ricorda belisi un Iucus Furinae , cioè un bosco sacro a una dea Furina; ma se questa dea Furina avesse nulla a che fare colle Erinni greche, ciò lo ignoriamo,sebbene gli antichi la identificassero.
Un’immagine delle Erinni è potentemente scolpita è nei tragici greci; ina v’è differenza grande dall’uno all’altro. Nell’Eumenidi di fischilo son dipinte come mostri somiglianti alle Gorgoni e alle Arpie, ma senza ali; son dette negre e abominande; un tristo umor cola dai loro occhi, han dei ser- penti per capelli, la lingua sporge dalla bocca e digrignano i denti; le vesti nere sono tenute su da una cintura rosseggiante di sangue. Il loro coro canta:
Già la potente Parca
A noi filando incommutabil sorte,
Tal n’assegnò vicenda:
Onde chi ‘l giusto varca,
Suoi congiunti ponendo a iniqua morte,
Noi fin che all’ Orco ei scenda
Perseguitiam, nè gir laggiù pur anco
Lasciam securo e franco.
tutte de’ reiPor le case a soqquadro e la fortuna
Quando morte al congiunto osa il congiunto
Recar, Tosto con rapido
Pie’ chi sparso ha col ferro il nuovo sangueNoi seguiam, benché forte; e lui raggiunto
Rendiam nud’ombra esangue….(Trad. Bellotti).
(Libera traduzione da William Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. London: Taylor, Walton, and Maberly. 1870)